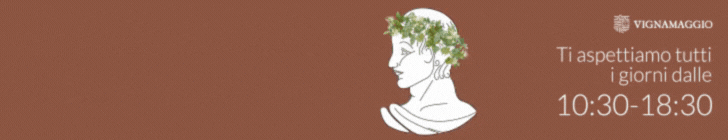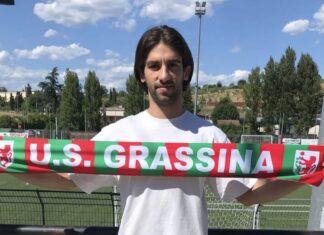Promemoria su quanto fa schifo il capitalismo.
Fino al 7 maggio c’era un negozio, ci ho lavorato per sei mesi ossia fino a marzo, prima che non mi venisse rinnovato il contratto in vista della chiusura… .
In attesa naturalmente che dietro a queste due arcate su via Cerretani a due passi dal Duomo di Firenze, apra una nuova attività sempre proprietà dello stesso Padrone, il quale si vede che, facendo due conti, ha valutato di poter guadagnare di più, infilando qui un altro marchio.
Gli operai lavorano da pochissimi giorni, ho sbirciato “dietro le quinte” e già non si riconosce più nulla… . La precarietà d’altronde non è solo per le persone, ma anche per i luoghi entro cui nel precariato esse devono barcamenarsi.
Di quei sei mesi passati con addosso quella polo nera ed il grembiule grigio porto con me ricordi agrodolci, nel senso che al tremendo e cannibale frenetico imperativo “VENDERE, VENDERE, VENDERE”; ha sempre fatto da contraltare una costante solidarietà tra colleghi che mi ha fatto vivere in maniera meno pesante anche i momenti più caotici (penso soprattutto alle festività natalizie, in cui il comprar bischerate diventa ancora più patologico ed il venderle di conseguenza).
Tolti i rapporti umani di cui conservo quasi esclusivamente bellissimi ricordi, è stata un’esperienza lavorativa utile a rafforzare in me la convinzione che un mondo così fa semplicemente ribrezzo.
Mesi passati sostanzialmente a cercar di rifilare frigoriferi a degli eschimesi.
Mesi ad imparare trucchetti per rifilare più roba ad ogni cliente… . La roba già la roba: più volte in quel periodo mi è venuta in mente la novella di Verga sull’accumulare, sul bisogno di possedere il superfluo.
I sassolini che si illuminano la notte, gli occhiali da cipolla, la bilancia a dinamo, la sveglia con tiro al piattello… . Roba che mai avrei creduto prima qualcuno potesse pensare di realizzare, figuriamoci di dover provare io a rifilare a qualcuno e per giunta di ritrovarmi ad essere contento di averlo fatto… .
Già perché poi la cosa più triste, a posteriori, è proprio ricordarsi quella sensazione di appagamento che avevo quando riuscivo a vendere a qualcuno, qualcosa di particolarmente inutile.
Ricordo di aver venduto una specchiera da 250 euro ad un padre alla ricerca di un regalo di compleanno per la figlia, era ancora vestito da lavoro, un muratore quasi sicuramente. Uno che quei 250 euro se li era sudati e io mi sono ritrovato a sfregarmi le mani per averlo convinto a fare quell’acquistone… . Che schifo.
Ma come si fa a sentirsi a Casa in un mondo in cui il modello di “impresa di successo” è questo?
Un’impresa che riesce a portare te – ultima ruota del carro con contrattino di 6 mesi – a chiudere la sera e farti girare le scatole se il negozio ha incassato 10 euro meno dell’anno prima quel giorno, se i parametri di vendita non vanno bene?
Già quei parametri, maledetti parametri: numeri, numeri, numeri… . Numeri che stabilivano se eri stato bravo o no. Pur di farli tornare (poi a pro di chi…), pur di poter dire di aver fatto il mio quel giorno; quanta paccottiglia ho rifilato a gente che pareva si sentisse proprio in dovere di buttar via soldi, pur di infilarsi in borsa qualcosa di inutile, sintomo di benessere economico e dunque d’una vita felice… .
“La fidelizzazione del cliente” gente ubriacata dal consumismo che orgogliosamente ti veniva a dire quanto fosse assidua compratrice dei “nostri” prodotti.
Quante volte mi sarebbe venuto di dire a qualcuno di questi clienti fedeli “guardi se ha tutta questa voglia di svuotarsi il portafoglio, qui fuori c’è un clochard, li dia a lui i suoi soldi che tanto il massaggiatore per il collo non le serve a lei e men che mai a chi lo ha da ricevere come regalo”, ma il mio ruolo era un altro: io avevo da vendere, sempre rigorosamente col sorriso stampato sulla faccia.
Poi la beffa l’ho presa io, due giorni prima della scadenza del contratto (fosse mai che smettessi prima di essere produttivo) quei 10 minuti in ufficio, la triste notizia (che eticamente ora penso di poter definire una liberazione) e via.
Com’è stato per me, così è stato per i miei colleghi “la proprietà ha altri piani” e così che tu sia lì da due mesi o da 15 anni, sei in balia dei “piani” di qualcuno che quando passa a visitare i propri punti vendita, pare meriti pure parecchi salamelecchi.
Immaginare un mondo diverso, migliore; non è un esercizio utopistico fine a sé stesso, è un metodo funzionale a sopravvivere in un mondo così in cui pare perfettamente normale che il fine ultimo dell’esistenza d’ognuno di noi, sia metterlo in tasca al nostro prossimo, sempre che tale prossimo non sia uno economicamente arrivato, in tal caso gli si deve obbedienza, sottomissione e gratitudine incondizionate.
Antonio Matteini
©RIPRODUZIONE RISERVATA