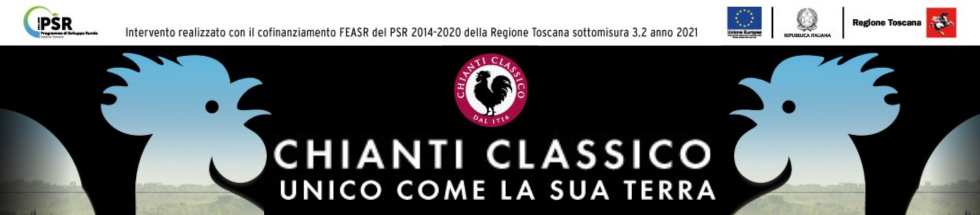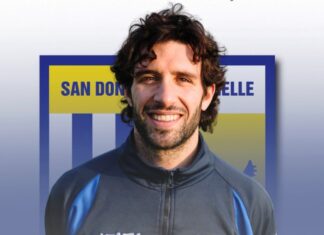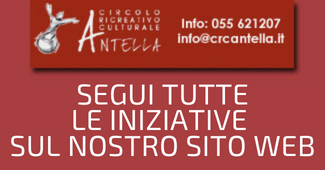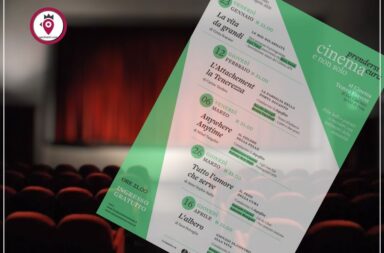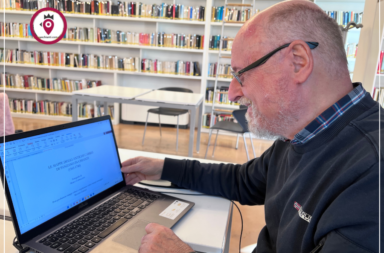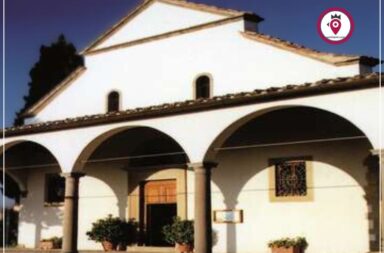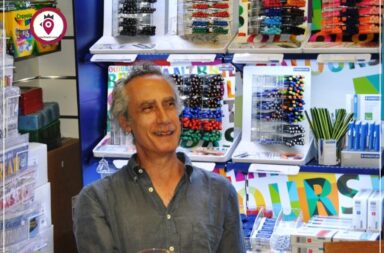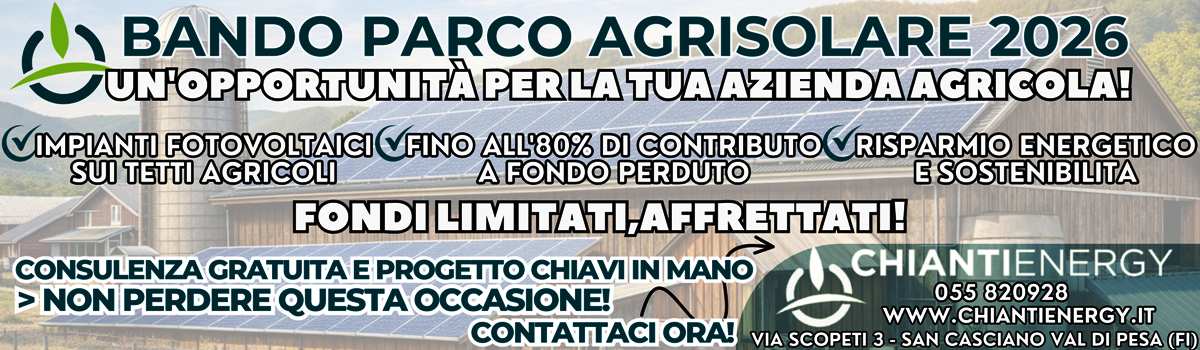La mediazione
Il condominio, inteso sia come contesto nel quale si abita sia come istituto giuridico che regolamenta i rapporti fra i comproprietari, è sicuramente un ambito nel quale si generano numerosi conflitti, che possono riguardare singoli condomini che litigano fra loro oppure condomini che litigano con il condominio o con l’amministratore oppure ancora il condominio che litiga con soggetti estranei alla compagine condominiale (si pensi ad esempio ai fornitori).
Parte di questi conflitti, in particolare quelli tra condomini, gran parte dei quali sono costituiti dalle classiche “liti tra vicini”, spesso vengono gestiti (e risolti) direttamente tra le parti o mediante l’ausilio di altri condomini o dell’amministratore (che fungono da pacieri), anche in sede assembleare.
In questi casi si parlerà di negoziazione (se le parti in lite gestiscono da sole il conflitto) o di forme più o meno embrionali di mediazione volontaria (nelle quali il soggetto che interviene come paciere può in qualche modo essere assimilato a un mediatore).
L’art. 5 del D.lgs. 28/2010 ha previsto la mediazione come condizione di procedibilità per numerose tipologie di controversie, dando vita ad altrettante forme di c.d. mediazione obbligatoria.
Ovviamente l’espressione “mediazione obbligatoria” deve essere intesa come semplice obbligo del tentativo di conciliazione e non certo del raggiungimento di un’intesa transattiva.
Le parti in lite sono infatti messe nelle condizioni di confrontarsi liberamente sui fatti controversi e in ogni momento dell’incontro possono abbandonare le trattative e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Proprio perché la mediazione dovrebbe essere percepita dalle parti come un’opportunità e non un onere, e perché non si possono comunque privare i cittadini del diritto di chiedere e ottenere una pronta risposta giurisdizionale in tutti quei casi in cui l’attesa dei tempi della mediazione potrebbe risultare addirittura dannosa in quanto potrebbe pregiudicare i relativi diritti, il Legislatore ha disposto che il tentativo obbligatorio di mediazione non impedisca la concessione di qualsivoglia provvedimento di urgenza o cautelare.
Se, però, il regolamento condominiale, prevede una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il Giudice o l’arbitro, su eccezione di parte è tenuto ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e a fissare la successiva udienza dopo 120 giorni.
La domanda di mediazione per le controversie condominiali deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del Tribunale nella quale il condominio è situato.
Per quanto concerne, la legittimazione a partecipare al procedimento e l’eventuale possibilità di più partecipanti, si ritiene che debba essere l’amministratore a partecipare alla mediazione, previa deliberazione assembleare. È tuttavia possibile, se la controparte lo consente e/o se il mediatore lo ritiene opportuno, che all’incontro partecipi anche qualche condomino.
La procedura di mediazione, in caso di esito positivo, si conclude, con il raggiungimento di un accordo tra le parti, con il quale vengono composti gli interessi in contrasto e che deve essere formalizzato per iscritto.
L’accordo di conciliazione ha natura contrattuale. La procedura dalla quale deriva, infatti, per sua stessa definizione, ha natura in tutto e per tutto privata e non decisionale. In particolare, l’accordo conciliativo non potrà mai essere assimilato alla sentenza o al lodo arbitrale.
Il contratto, infatti, pur avendo forza di legge fra le parti, non produce alcun effetto di accertamento di un diritto controverso, prerogativa propria del procedimento giurisdizionale ordinario.
D’altra parte, occorre evidenziare come, per assicurare una maggiore efficacia all’accordo conciliativo, il D.lgs. n. 28/2010 abbia previsto la possibilità che lo stesso, purché sottoscritto anche dai legali delle parti, acquisti efficacia di titolo esecutivo e possa dunque essere utilizzato per ottenere forzosamente l’esecuzione dell’obbligazione dedotta nel contratto.
Le parti non devono però cadere nell’errore di considerare conclusa la mediazione con il raggiungimento dell’accordo. Spesso, infatti, un’errata formalizzazione della conciliazione può mandare in fumo anche la soluzione conciliativa più brillante. Da qui l’importanza di redigerne correttamente il contenuto in modo chiaro e condiviso, in modo da evitare che eventuali differenze di linguaggio e/o di terminologia possano provocare incomprensioni future tra le parti.
Spetta, infine, all’assemblea condominiale il compito di deliberare in merito all’accordo di conciliazione e in caso positivo sarà l’amministratore a sottoscriverlo.
Impugnazione delle deliberazioni (in sede giurisdizionale)
L’adozione di deliberazioni da parte dell’assemblea, che costituisce la modalità attraverso la quale si forma e si manifesta all’esterno la volontà della maggioranza della compagine condominiale, costituisce l’esito di un complesso procedimento.
La deliberazione assembleare adottata nel rispetto delle predette disposizioni e con le maggioranze ivi prescritte rappresenta dunque la volontà del condominio e vincola tutti i condomini, anche quelli che abbiano votato contro tale decisione o non siano stati presenti alla votazione.
Al contrario, la deliberazione che sia stata adottata senza il rispetto delle predette disposizioni è invalida e tale invalidità potrà essere accertata soltanto in sede giudiziale con una decisione che, a seconda della gravità del vizio, la priverà di effetti sin dall’inizio (in caso di dichiarazione di nullità) o a partire dalla pubblicazione della sentenza (in caso di annullamento).
La distinzione fra ipotesi di nullità e annullabilità delle deliberazioni assembleari alle quali si accennava nel precedente paragrafo, non essendo stata oggetto di precise indicazioni da parte del Legislatore, almeno fino alla recente riforma di cui alla Legge n. 220/2012, ha portato all’elaborazione di una casistica giurisprudenziale quanto mai intricata e, a volte, contraddittoria. I giudici di legittimità hanno così chiarito che devono qualificarsi nulle le delibere:
- prive degli elementi essenziali;
- con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume);
- con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea;
- che incidono sui diritti individuali sulle cose o sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
- le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto.
In via residuale devono invece qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.
Con riferimento ai termini per impugnare, pur se con diverse sfumature, la giurisprudenza ha sempre sostenuto che il disposto di cui all’art. 1337 c.c. ante riforma, e il relativo termine di impugnazione di trenta giorni, attengano soltanto alle delibere annullabili e non anche a quelle nulle, per le quali, stante la natura di accertamento della relativa azione giudiziale, non vi è alcun termine di decadenza.
Queste conclusioni sono state confermate dal Legislatore della riforma del 2012 che, come vedremo a breve, ha operato una riscrittura dell’art. 1137 c.c., chiarendo molti dei punti controversi relativi all’impugnazione giudiziale delle delibere assembleari, proprio a partire dalla questione del regime di invalidità delle stesse.
Per quanto riguarda la legittimazione attiva ad agire in giudizio, la legge 220/2012 ha opportunamente specificato che questa spetta tanto ai condomini presenti in assemblea e che abbiano votato in senso contrario all’approvazione della delibera quanto a quelli assenti quanto, infine, a quelli che, pur avendo partecipato alla riunione condominiale, si siano astenuti dal voto.
Nell’ipotesi di comproprietà dell’unità immobiliare compresa nel condominio, la legittimazione attiva spetta a ciascuno dei comproprietari.
Anche l’acquirente di un’unità immobiliare in condominio può impugnare la deliberazione adottata in una precedente assemblea alla quale abbia partecipato il venditore (suo dante causa), a condizione che quest’ultimo non abbia votato a favore e che l’acquirente abbia provveduto alla comunicazione dell’acquisto all’amministratore del condominio. Infine, anche per quanto riguarda i conduttori si ritiene che l’attribuzione del diritto di voto in assemblea nelle materie di cui all’art. 10 della Legge n. 392/78 valga a conferire implicitamente agli stessi il potere di impugnare le relative deliberazioni assembleari
A tale scopo, il termine di decadenza di trenta giorni per l’impugnazione della delibera condominiale, sempre secondo la nuova versione dell’art. 1137 c.c., decorre dalla data dell’assemblea per i dissenzienti e gli astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Nel caso in cui venga impugnata una deliberazione assembleare o sia presentata qualche altra domanda giudiziale nei confronti del condominio, la legittimazione passiva a stare in giudizio, in nome e per conto di quest’ultimo, spetta all’amministratore.
Egli può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio condominiale. Qualora, invece, la domanda riguardi interessi prettamente individuali dei singoli condomini, l’azione dovrà essere proposta direttamente contro questi ultimi, che avranno l’onere di costituirsi in giudizio.
Il recupero della morosità condominiale
Accade sempre più spesso che i condomini versino in ritardo, o non paghino affatto, la propria quota di spese spettante per la gestione dei beni e dei servizi comuni.
La crisi che ha attraversato l’Italia in questi anni – che sarà purtroppo fortemente aggravata dall’epidemia di Covid-19 che sta imperversando in queste settimane – ha infatti messo a dura prova la tenuta economica delle famiglie, costrette a tagliare le proprie spese.
In questo modo, però, i comproprietari in regola con i pagamenti si vedono a loro volta costretti ad anticipare, in tutto o in parte, le quote dovute dai morosi per mantenere in equilibrio la contabilità condominiale ed evitare la sospensione di alcuni servizi (si pensi, ad esempio, all’acqua e al riscaldamento), senza avere certezze in merito alla possibilità di recuperare le somme versate in aggiunta a quelle dovute e ai tempi a tal fine necessari.
Entrando un attimo nel dettaglio, ’art. 1123, comma 1, c.c. enuclea il criterio generale di ripartizione delle spese condominiali, in base al quale i contributi dovuti per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio “sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Quindi, salva una diversa volontà espressa dai condomini in un regolamento contrattuale o in una deliberazione o altro atto dal quale risulti il consenso unanime, tutte le spese che attengono alla gestione dei beni comuni vanno suddivise in base ai millesimi di proprietà attribuiti a ciascun comproprietario.
Da ciò se ne ricava che l’obbligo dei condomini di contribuire alle spese comuni ha carattere preventivo, nel senso che gli stessi sono tenuti ad anticipare all’amministratore le somme necessarie alla gestione del condominio una volta approvate dall’assemblea sulla base del prospetto da questi presentato e del relativo piano di riparto.
Detto obbligo è, per sua natura, preesistente all’approvazione, da parte dell’assemblea, dello stato di ripartizione delle spese, che ha un valore meramente dichiarativo.
Ancora, si deve ritenere pienamente legittimo il comportamento dell’amministratore che, nel presentare all’assemblea il rendiconto per la sua approvazione, indichi in un’apposita sezione il nome dei condomini in mora nei pagamenti e l’importo delle quote non versate da ciascuno di essi.
Infatti l’espressa indicazione, nei documenti relativi alla gestione del condominio, della situazione di morosità di un condomino non costituisce affatto di per sé violazione della privacy, proprio perché l’eventuale mancato pagamento di spese condominiali da parte di un qualsivoglia comproprietario è destinato a essere evidenziato necessariamente nel rendiconto delle spese di gestione.
Inoltre, la riforma del 2012 ha codificato l’obbligo di far transitare su un conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini e dai terzi, nonché quelle erogate in nome e per conto del condominio. La nuova disposizione prevede altresì che ciascun condomino possa, sempre per il tramite dell’amministratore, prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della relativa rendicontazione periodica.
Il nuovo testo dell’art. 63 Disp. att. c.c., introdotto dalla legge n. 220/2012 di riforma della disciplina del condominio negli edifici, pur mantenendo le altre condizioni di cui sopra, ha opportunamente eliminato la necessità della preventiva indicazione nel regolamento condominiale della possibilità per l’amministratore di agire in questa direzione.
Con la nuova disposizione normativa, quindi, l’amministratore condominiale ha una freccia in più al proprio arco per cercare di obbligare i condomini al puntuale rispetto delle scadenze di pagamento e la sospensione dell’utilizzazione dei beni e dei servizi comuni suscettibili di godimento separato si ritiene possa essere un ottimo stimolo per cercare di arginare le dimensioni davvero abnormi che attualmente la questione della morosità condominiale ha raggiunto.
Nel caso in cui, però, il legale del condominio debba comunque procedere al recupero giudiziale del credito, le strade a sua disposizione sono sostanzialmente due: il procedimento di cognizione ordinario di cui agli artt. 163 ss. c.p.c. oppure il procedimento speciale di ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., anche se la soluzione più agevole è sicuramente la seconda.
La norma in questione prevede un trattamento davvero preferenziale per questa tipologia di crediti, a fronte dei quali il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice è sempre immediatamente esecutivo, anche nel caso in cui lo stesso venga opposto dal condomino moroso: questo vuol dire che il condominio che abbia ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo può immediatamente procedere all’esecuzione forzata nei confronti del condomino debitore, senza temere gli effetti di una eventuale opposizione (con la quale, però, il condomino moroso potrà chiedere, in presenza di particolari requisiti, la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto).
Il contenzioso con i terzi (fornitori in particolare)
Nel corso della propria gestione annuale il condominio si trova a essere al centro di numerosi rapporti obbligatori, sia come creditore sia come debitore.
A tal proposito, si è soliti distinguere tra obbligazioni condominiali interne ed esterne, laddove con le prime viene fatto riferimento alla ripartizione delle spese tra i condomini mentre le seconde riguardano i rapporti giuridici con i terzi gestiti dall’amministratore in nome e per conto del condominio.
Un’altra distinzione che ha assunto un’importanza fondamentale a livello condominiale è quella tra obbligazioni solidali e obbligazioni parziarie.
La questione delle obbligazioni condominiali è resa complicata dal fatto che il condominio nel nostro ordinamento non ha personalità giuridica, ovvero non costituisce un autonomo centro di imputazione di diritti e doveri, i quali fanno quindi capo ai singoli condomini.
Di conseguenza, secondo le Sezioni Unite, poiché il contratto stipulato dall’amministratore in nome e nell’interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti di questi ultimi, una volta conseguita nel processo la condanna dell’amministratore il creditore può procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli comproprietari, ma rigorosamente nei limiti della quota di ciascuno di essi.
Dopo la riforma del 2012, inoltre, il creditore potrà agire nei confronti dei condomini in regola coi pagamenti dopo aver escusso gli altri.
Come appena accennato, a proposito degli effetti della sentenza di condanna, l’amministratore può essere citato in giudizio per rispondere in nome e per conto del condominio nelle cause riguardanti le parti comuni dell’edificio (rappresentanza processuale passiva). Egli, però, può agire in giudizio, sia contro i terzi che contro gli stessi condomini in nome e per conto del condominio (rappresentanza processuale attiva).
Il dissenso del condomino alla lite
Tra i vari previsti in tema di controversie condominiali, parliamo adesso del particolare istituto del dissenso dei condomini rispetto alle liti condominiali, la cui applicazione è spesso frutto di equivoci, alcuni dei quali ancora non del tutto chiariti in maniera definitiva.
È immediatamente opportuno evidenziare come la disposizione in questione contenga una espressa deroga al regime ordinario della ripartizione delle spese condominiali di cui all’art. 1123 c.c..
Le spese legali che il condominio sia stato eventualmente condannato a rifondere alla controparte all’esito del giudizio andrebbero infatti ripartite tra tutti i condomini secondo la propria quota millesimale.
In base all’art. 1132 c.c., invece, purché ne ricorrano i presupposti, uno o più condomini possono sottrarsi a tali spese, con l’effetto che le stesse andranno sostenute in maggior misura dagli altri comproprietari.
Questa sorta di “scudo”, opera però solo nei rapporti interni, ossia tra i condomini, e non anche in quelli esterni, ben potendo rivalersi anche sul condomino dissenziente (che potrà successivamente agire in rivalsa) il soggetto che vanti un credito nei confronti del condominio sulla base del provvedimento giudiziale reso all’esito della lite.
Di questo strumento può avvalersi solo il condomino che abbia votato contro la delibera o si sia astenuto, nonché quello che non abbia partecipato all’assemblea. Detto diritto deve essere però esercitato entro un preciso termine di decadenza.
Il condomino è infatti chiamato ad attivarsi entro trenta giorni da quello in cui ha avuto notizia della deliberazione, dunque a decorrere dall’assemblea, per quelli che vi abbiano partecipato, oppure, per gli assenti, a decorrere dal ricevimento del relativo verbale. Il dissenso deve essere esplicito, formulato per iscritto e notificato all’amministratore
A completamento del quadro, la deliberazione assembleare che non rispetti la posizione del condomino che abbia tempestivamente esercitato il diritto di cui all’art. 1132 c.c., imponendogli il pagamento pro quota delle spese di lite, è poi considerata dalla Suprema Corte non semplicemente annullabile, bensì addirittura nulla.
Revoca giudiziale dell’amministratore
Generalmente il rapporto che intercorre tra il condominio e l’amministratore è sempre stato ricondotto al contratto di mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.), pur differenziandosi da questo per l’obbligatorietà della sua costituzione, nonché per il contenuto e gli effetti.
La Legge n. 220/2012 ha innovato profondamente la figura dell’amministratore condominiale.
Poiché il rapporto che lega l’amministratore alla compagine condominiale è di tipo contrattuale ne consegue che i condomini (mandanti) possono sciogliere in ogni momento il vincolo che li lega al proprio mandatario senza necessità di individuare una giusta causa.
La revoca del mandato all’amministratore, così come la sua nomina, deve ovviamente provenire dall’assemblea, l’organismo deputato alla formazione della volontà condominiale. L’art. 1136 c.c. prevede il medesimo quorum deliberativo per entrambe le deliberazioni, ossia la maggioranza dei presenti alla riunione che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
In aggiunta alla revoca assembleare, il Legislatore ha previsto una sorta di valvola di sfogo, ovvero la revoca giudiziale, consentendo anche a un solo condomino di richiedere al Tribunale di valutare l’operato dell’amministratore e disporne ove occorra la cessazione dell’incarico con un provvedimento giudiziale; questo tipo di revoca, a differenza di quella assembleare, è possibile soltanto ove ricorra una giusta causa o, meglio, una grave irregolarità commessa dall’amministratore nello svolgimento del proprio incarico.
CHI SONO
Dottor Marco Suisola nato a Firenze il 25 aprile 1978 svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999.
Associato inizialmente alla Federazione Nazionale Amministratori fino al 2015 per poi diventare socio fondatore della Confartamministratori, nella quale ha rivestito la carica di tesoriere e parte integrante del CDA. Di recente è iscritto anche all’associazione Gesticond.
Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/2014 . Ha conseguito la qualifica di Revisore condominiale nel 2017.
Conseguito attestato per corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto condominiale presso l’Università di Firenze nell’anno 2006. Frequentato il corso per ottenere la qualifica di consulenze tecnico di ufficio in ambito condominiale nell’anno 2014.
A dicembre 2018 ha conseguito la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici come esperto giuridico immobiliare. Ad oggi il mio studio è composto da 8 dipendenti il sottoscritto un collaboratore e due tecnici interni.
Ci avvaliamo di tutti gli strumenti che possono garantire una copertura ed una flessibilità dei servizi e garantiamo una reperibilità di 7 giorni su 7. La società ha sede in via Fontebuoni 4/6 Firenze: www.marcosuisola.com.
@RIPRODUZIONE RISERVATA