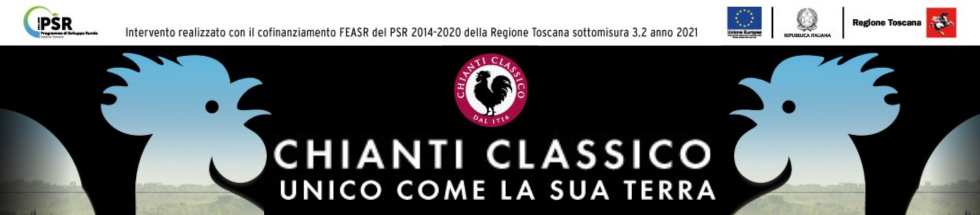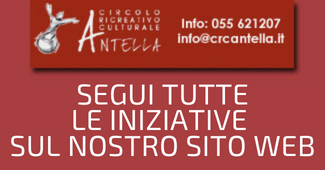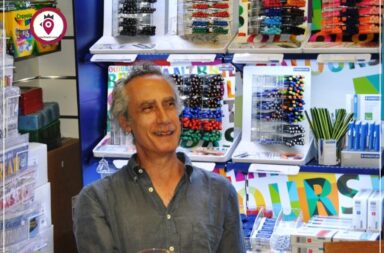Nel campo della psicologia dello sviluppo e non solo, è molto tempo che si sente parlare della teoria dell’attaccamento, teoria che ha riscosso molto successo, e che ha permesso di spiegare quello che avviene nella relazione madre-bambino fin dai primi mesi di vita e come questo si ripercuota anche in certi comportamenti dell’adulto, soprattutto nella coppia.
Questa teoria, messa a punto dal ricercatore John Bowlby si è poi sviluppata tramite la collaborazione con un’altra ricercatrice, Mary Ainsworth la quale, dopo aver svolto un intenso lavoro di ricerca, si era resa conto di come nella nostra specie, il legame del bambino con la madre si struttura fin dalla nascita.
Dallo studio era emerso che il bambino esplorava il suo ambiente se percepiva la madre come una “base sicura” da cui allontanarsi e tornare in caso di necessità.
Successivamente a queste osservazioni la Ainsworth costruì vari progetti di ricerca, il Baltimor Longitudinal Project e la Strange Situation, grazie ai quali è stato dimostrato come l’espressione delle emozioni, la loro regolazione e certi comportamenti messi in atto dal bambino sono in funzione del tipo di accudimento ricevuto in età precoce, tra i primi mesi ed il secondo anno di vita.
E’ stato dimostrato come soprattutto due atteggiamenti messi in atto dalla madre incidano significativamente sul bambino; la sensibilità, ovvero la capacità della madre di riconoscere certi segnali inviati dal bambino e di capire di cosa ha bisogno e la responsività, ovvero la prontezza della madre nel rispondere ad essi.
Ciò che è stato osservato durante gli esperimenti, caratteristico di ogni “coppia” madre-bambino, potrebbe essere paragonato ad una sorta di danza che si instaura fin dalla nascita.
Le prime richieste di fame o di conforto sono emesse tramite il pianto dal bambino, alle quali la madre risponde velocemente (responsività) ed in modo adeguato, comprendendo via via di cosa il bambino ha bisogno (sensibilità) per il loro soddisfacimento. A sua volta, il bambino impara ad adattare il proprio comportamento nei confronti di colui o colei che l’accudisce.
Si è visto come piano piano, se tali richieste sono soddisfatte ripetutamente ed entro un certo periodo di età, il bambino si crea in qualche modo delle aspettative circa la figura che lo accudisce. Aspettative che permettono ai bambini, dopo un certo periodo, di ricorrere al pianto solo quando lo stress e lo sconforto sono effettivamente elevati.
Quello che è emerso da questi studi è che la capacità nei bambini di poter affrontare lo sconforto e certi tipi di stress, anche in assenza della madre, appare fin da piccoli in un’età molto più precoce di quanto si pensasse e che questa capacità dipende anche da quanto la madre sia stata precedentemente responsiva e sensibile.
Inoltre, i bambini sembrano mettere in atto una serie di comportamenti che hanno l’effetto di far avvicinare la madre e, nei primi mesi di vita, tali comportamenti sono diretti in modo preferenziale verso di essa, ad esempio possono piangere se la madre esce dalla stanza ma non se esce un’altra persona.
Sembrerebbe che solo dopo i sei mesi vita, questi comportamenti si organizzino in modo sempre più volontario e costruito, e, generalmente, rivolti quasi unicamente nei confronti della figura che non solo ha dato loro ciò di cui avevano bisogno nei mesi precedenti ma anche in modo attento e responsivo.
A quel punto, la figura familiare che più ha aderito a tali regole (responsività e sensibilità) diventa per il bambino la figura chiamata di attaccamento. Tradotto, la figura verso la quale il bambino ha una preferenza non è detto che sia solo la madre anche se generalmente è così.
Ovviamente per quanto possa sembrare una cosa molto semplice sulla carta, questo scambio relazionale tra la figura di attaccamento e il bambino non è detto che sia così automatico e facile ma si tratta sempre di una capacità che va appresa piano piano e non con pochi sforzi, sia per il bambino che per il genitore.
Secondo quanto osservato, dopo i 18 mesi anche il bambino si adatta alle necessità dell’adulto, aspetta il suo ritorno e accetta di stare per un po’ da solo. Dopo questo periodo si formano quelli che vengono chiamati Modelli Operativi Interni, una sorta di schema mentale che si costruisce in base alle precedenti esperienze con la figura di attaccamento e che sembra essere alla base di molti comportamenti ed aspettative che si manterrebbero anche da adulti.
Da quello che abbiamo visto con ricerche successive, questi comportamenti ed aspettative per quanto generalmente siano stabili in età adulta, in qualche modo potrebbero cambiare durante tutto l’arco di vita.
Bibliografia
Carli L. (1995). “Attaccamento e rapporto di coppia”. Raffaello Cortina, Milano.
Crittenden P. (1999). “Attaccamento in età adulta”. Raffaello Cortina, Milano.
Attili G. (2007). “Attaccamento e costruzione evoluzionistica della mente. Normalità, patologia, terapia”. Raffaello Cortina, Milano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA